Quando si subisce un infortunio si rompe qualcosa di più del nostro corpo. Si rompe l’abitudine di fare le normali cose quotidiane, così come anche la percezione di essere efficaci e autosufficienti.
Il giorno appena dopo quello dell’incidente, si pensa a se stessi come a qualcuno che non c’è più, nel senso del termine più fantasmatico che esista. Si guardano gli oggetti che poco prima erano stati toccati o spostati, la stanza in cui si era stati prima del fatto, perfino gli abiti buttati sulla sedia acquistano una loro importanza, come se tutto il contesto appartenesse ad un prima di indecifrabile temporalità. Eppure era accaduto qualche ora fa. È la routine che salta, che si rompe, che si frattura insieme alla rotula.
Non ci facciamo caso finché non accade e vi assicuro che è davvero una sensazione strana.
Perché quando ti rompi il ginocchio cedono tutte le certezze, principalmente quelle di poterti sostenere da solo e di fare. Fare nel senso di produrre, ma soprattutto di stare in movimento. È la relazione che cambia: non sono più io che vado incontro alle persone, ma loro ora devono muoversi verso di me.
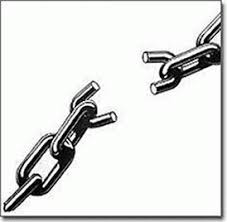 Quando ti rompi il ginocchio cede quindi la relazionalità e si slatentizzano conflitti fino a quel momento tenuti sotto controllo o semplicemente negati.
Quando ti rompi il ginocchio cede quindi la relazionalità e si slatentizzano conflitti fino a quel momento tenuti sotto controllo o semplicemente negati.
La frattura fisica determina una frattura psichica e sociale in modo inevitabile. Si devono rinegoziare i ruoli e i compiti all’interno di un sistema familiare, così come prodigarsi per una migliore gestione degli stati emotivi sia del care-giver che chiaramente dell’infortunato. La relazione che cura non è infatti una cosa semplice e in questo legame intervengono aspetti profondi spesso non bene elaborati che coinvolgono entrambe le parti in questione. Colui che ha subito il trauma è certamente il soggetto che richiede la maggior cura delle attenzioni, non solo da un punto di vista pratico (l’essere aiutato a compiere i normali gesti quotidiani dall’alimentazione all’igiene, così come pure semplici faccende), ma anche psicologico perché il soggetto è pervaso da un’ondata emotiva difficile da arginare, a causa della sua nuova condizione. Una sorta di regressione forzata che sancisce un prima e un dopo, fuori dalla nostra volontà e ovviamente senza il nostro controllo, poiché dipendiamo in tutto e per tutto dalla persona che si occupa di noi. La condizione che si subisce stando a letto, quasi immobile, non attiene soltanto allo stato contingente ma riattiva tutta una serie di dinamiche che fanno parte inevitabilmente del nostro passato e che riemergono prorompenti senza un qualche preavviso imponendosi come stato di fatto. Tutti almeno una volta nella vita siamo stati costretti a dipendere da qualcuno, prima di svincolarci verso un’autonomia che fa di noi persone sufficientemente adulte e mature; parlo dell’infanzia ma anche di tutte quelle situazioni critiche che richiamano l’attenzione: la gravidanza e la maternità, la senilità, il lutto, e tutte le condizioni di inabilità di tipo temporaneo o definitivo.
La gestione degli stati emotivi è dunque questione delicata soprattutto per chi subisce il trauma per il suo sentirsi inutile a se stesso (l’impossibilità di fare) e la percezione invece di causare molto all’altro (per il suo essere richiedente). Non posso fare niente, eppure gli altri sono costretti a dover fare molto per me, è quell’ambivalenza quasi forzata che stona con il naturale percorso che si verifica nelle situazioni di aiuto.
 Ed è per questo che la gestione degli stati emotivi non attiene solo al malato, ma pervade soprattutto il care-giver che deve perciò rinegoziare i propri conflitti interiori per occuparsi della persona fragile con cui si relaziona. E ciò accade spesso quando la relazione che cura è di tipo familiare piuttosto che estranea. La presenza di dinamiche psicologiche in chi ci troviamo di fronte e che dobbiamo aiutare, è presente in ciascuno di noi, ma è ancor più amplificato quando interessa un genitore o un fratello.
Ed è per questo che la gestione degli stati emotivi non attiene solo al malato, ma pervade soprattutto il care-giver che deve perciò rinegoziare i propri conflitti interiori per occuparsi della persona fragile con cui si relaziona. E ciò accade spesso quando la relazione che cura è di tipo familiare piuttosto che estranea. La presenza di dinamiche psicologiche in chi ci troviamo di fronte e che dobbiamo aiutare, è presente in ciascuno di noi, ma è ancor più amplificato quando interessa un genitore o un fratello.
La frattura infrange dei confini, dei ruoli, dei ponti che si erano costruiti durante l’arco di sviluppo del sistema familiare: si riattivano conflitti, alleanze, si soppesano le parole e i gesti. Il tutto in una condizione che non lascia scampo all’evitamento o alla fuga. Per un’immobilità che non è propria soltanto di chi ha subito il trauma. Ecco perché nelle professioni di aiuto è difficile evitare quel carico emotivo che chiamiamo burn out. Non si vive solo negli ospedali o nelle professioni istituzionalizzate. È un affare comune a tutti coloro che si prendono cura dell’altro. Anche nella mia professione sia che si svolga tra le pareti di uno studio che in un contesto sanitario pubblico.
I giapponesi dicono che un vaso rotto sarà più bello di prima, per la loro antica arte (kintsugi) di colmare la frattura con dell’oro che salda, rinforza e restituisce un nuova immagine all’oggetto. Potremmo dire lo stesso delle relazioni e, di questo sono convinta, è sempre un bene ricostruire qualcosa di spezzato, non con nuove parti ma con quelle che sono cadute a terra nell’urto. Non è forse questo il senso della mia professione?  Presto toglierò il gesso e dalla radiografia si vedrà la mia rotula risanata. Il callo osseo, come l’oro, avrà colmato la frattura ed io potrò riprendere i miei passi. Non sarà facile e sarà doloroso, ma fa parte del processo. Neppure crescere è facile: si cade e ci si rialza, anche se doloranti. E non è solo un discorso fisico. Il bimbo che impara a camminare e chi riprende in mano la sua vita dopo tante sofferenze. Perché la vita è una continua crescita e a volte è bene farlo insieme.
Presto toglierò il gesso e dalla radiografia si vedrà la mia rotula risanata. Il callo osseo, come l’oro, avrà colmato la frattura ed io potrò riprendere i miei passi. Non sarà facile e sarà doloroso, ma fa parte del processo. Neppure crescere è facile: si cade e ci si rialza, anche se doloranti. E non è solo un discorso fisico. Il bimbo che impara a camminare e chi riprende in mano la sua vita dopo tante sofferenze. Perché la vita è una continua crescita e a volte è bene farlo insieme.
A questo proposito, consiglio di leggere La rappresentazione mediatica del bambino ospedalizzato nella sezione che affronta il delicato rapporto medico (care-giver) e paziente.

